
La prima edizione del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia si svolge a Sanremo nel 1987 su iniziativa dei coordinatori delle diverse sedi dei dottorati in filosofia. Nella realizzazione di questa prima edizione hanno un ruolo decisivo Pietro Rossi e Flavio Baroncelli ma – soprattutto per le edizioni successive – forniscono un contributo importante anche Franco Alessio, Enrico Berti, Giuseppe Cambiano, Giuseppe Cantillo, Ettore Casari, Italo Cubeddu, Alessandro Ghisalberti, Gabriele Giannantoni, Eugenio Lecaldano, Paolo Parrini, Gregorio Piaia, Stefano Poggi, Armando Rigobello, Paolo Rossi, Antonio Santucci, Valerio Verra e Carlo Augusto Viano. Dalla prima edizione si sono infatti succedute numerose edizioni, tenute in varie sedi e su iniziativa di diversi enti e coordinatori. Pur cambiando parzialmente la formula e il modello organizzativo, le intuizioni originarie sono tuttora l’asse fondamentale dell’iniziativa.
OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Fin dall’inizio, gli scopi dichiarati dell’iniziativa sono almeno quattro. In primo luogo, il Convegno mira a consentire ai dottorandi di avere un’occasione di incontro e di conoscenza reciproca, così da sviluppare relazioni di ricerca fondamentali per costruire sia i contenuti delle loro tesi di dottorato, sia una rete di contatti e prospettive necessarie per lo sviluppo delle loro carriere. In secondo luogo, l’iniziativa intende costruire un momento di discussione, di dibattito e di confronto tra i dottorandi e i docenti maggiormente esperti delle loro tematiche di ricerca, sulle quali pertanto possono ricevere importanti indicazioni di modifiche, integrazioni, revisioni: in questo modo i dottorandi possono aprire i loro orizzonti di studio al di là delle metodologie prevalenti nelle loro sedi universitarie, sottoponendo a un uditorio qualificato la propria prospettiva di studio così da ottenerne una verifica critica e un’occasione di crescita. In terzo luogo, il Convegno intende convocare ai propri lavori tutte le varie “anime” della filosofia italiana, nessuna esclusa: dalla logica alla filosofia teoretica, dalla storia della filosofia all’estetica, dalla filosofia morale alla filosofia del linguaggio e alla filosofia politica. Un tale pluralismo non è utile solo ai dottorandi, ma anche agli stessi professori di filosofia, che possono infatti trovare occasioni di apertura e di confronto che non sempre si realizzano nell’ordinaria vita accademica. Infine, il Convegno rende possibile realizzare una “mappa” – molto indicativa, seppur ovviamente parziale – dei contenuti e delle metodologie della ricerca filosofica italiana e delle diverse scuole di pensiero che la compongono e che, nel corso del tempo, si trasformano e si modificano, consentendo così di verificare i mutamenti tematici e di prospettiva che attraversano l’accademia italiana nelle sue diverse sedi. Proprio per meglio realizzare questo scopo, fin dalle prime edizioni del Convegno viene creato un organo “informale”, il Coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia il cui scopo è – oltre a quello di garantire il livello scientifico del Convegno – realizzare una rete tra le sedi universitarie dei dottorati di ricerca in filosofia che permetta un dialogo tra le diverse impostazioni accademiche, metodologiche e culturali.
PRINCIPALI CAMBIAMENTI
Dal 1987 a oggi si sono svolte numerose edizioni, tenute in varie sedi e cambiando parzialmente la formula e il modello organizzativo, senza tuttavia modificare le intuizioni originarie. Rispetto a tali cambiamenti, possiamo qui ricordarne i principali: per esempio il fatto che, ormai da molti anni, al Convegno partecipano dottorandi del secondo anno (e non del terzo, come avveniva inizialmente, anche per il motivo che nei primi cicli i corsi di dottorato avevano durata quadriennale), visto che sembra importante fornire loro un momento di discussione e di confronto in una fase che non è ancora quella finale della ricerca, così da offrire spunti e stimoli utili per la stesura della tesi. Un altro cambiamento consiste in un progressivo allargamento del numero dei docenti coinvolti come direttori di sessione nel Convegno, a cui corrisponde la costruzione di sessioni di discussione meno numerose e più specialistiche (e quindi meno centrate su ampi contenitori disciplinari e/o tematici). Un ulteriore cambiamento consiste nella conclusione dell’esperienza del Coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia, visto che – almeno dal 2013 – cambia radicalmente la struttura dei dottorati in Italia, che non sono più principalmente disciplinari ma, in molti casi, diventano contenitori per le diverse aree di ricerca (nel nostro caso quelle “umanistiche”, tanto da mettere insieme la filosofia con la letteratura, la storia con la linguistica, la pedagogia con la storia): pertanto, a causa di questo cambiamento dettato dalle politiche ministeriali, i dottorandi in filosofia non si trovano più solo all’interno dei dottorati specificamente dedicati alla filosofia, ma anche in quelli genericamente “umanistici” (o con altra titolazione).
FASI STORICHE DEL CONVEGNO
Al di là di questi – e di altri di minor conto – mutamenti organizzativi, la finalità del Convegno rimane immutata: creare uno spazio di confronto e di discussione, di conoscenza e di relazione tra dottorandi e professori, oltre che tra gli stessi dottorandi. Ma, al netto di questa continuità ideale, nella lunga storia del Convegno possiamo individuare almeno cinque diverse fasi, di cui in questo sito troviamo alcune testimonianze nelle sezioni dedicate alle edizioni e all’archivio.
PRIMA FASE (1987-1994)
La prima è quella che si svolge tra 1987 e 1994, con sedi sempre itineranti (Sanremo, Siena, Sorrento, Urbino, Cosenza) e con diversi enti organizzatori. In questa fase, dopo la creazione dell’iniziativa per mano di Pietro Rossi, il Segretario del Coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia diventa prima Paolo Parrini, poi Enrico Berti, che – anche nella sua veste di Presidente della Società Filosofica Italiana – tiene l’incarico fino alla fine del 1996, quando viene rilevato da Gregorio Piaia.
SECONDA FASE (1995-2000)
Già a partire dal 1995 si apre però una seconda fase della storia del Convegno, per impulso di Enrico Berti e di Paolo Rossi, i quali creano le condizioni per una stabilizzazione organizzativa dell’iniziativa, non più lasciata alla spontaneità e alla volontarietà delle diverse sedi universitarie. Nel 1995 viene infatti stipulato un accordo tra l’Istituto Antonio Banfi di Reggio Emilia (il cui direttore scientifico in quegli anni è proprio Paolo Rossi) e l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per un’organizzazione alternata del Convegno, non solo gestionale ma anche “geografica” (e infatti il Convegno si terrà un anno al Nord, un anno al Sud). Tale alternanza termina nel 2000 e vede realizzare tre edizioni a Reggio Emilia e una ciascuna a Ischia (Napoli), Chia Laguna (Cagliari) e Gallipoli (Lecce).
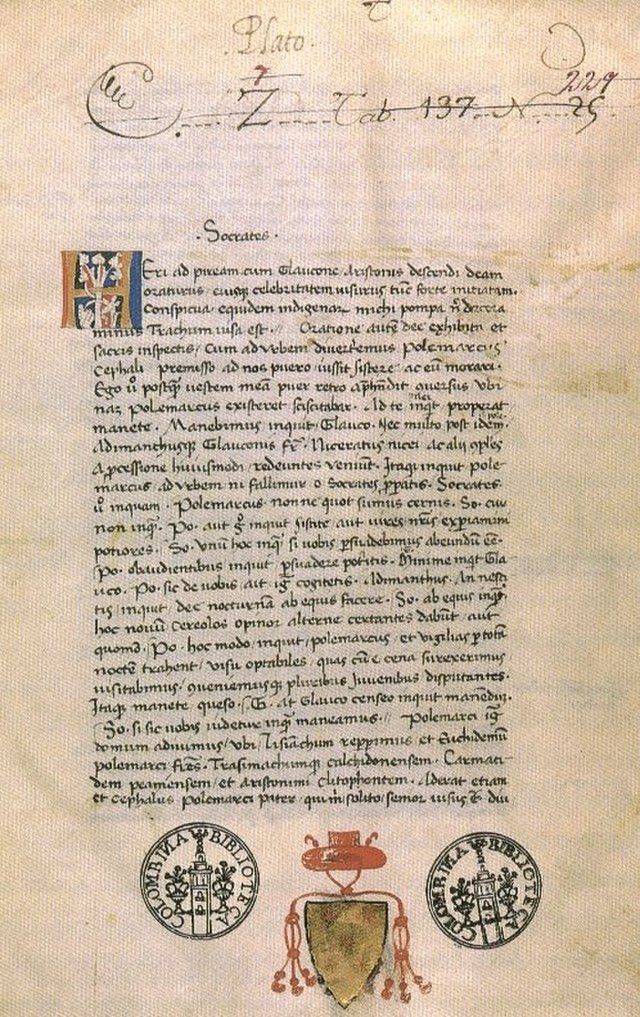
TERZA FASE (2001-2012)
Dal 2001 al 2012 si svolge la terza fase della storia del Convegno, che si tiene annualmente a Reggio Emilia grazie al contributo dell’Istituto Antonio Banfi. Gregorio Piaia termina il suo incarico di Segretario del Coordinamento nazionale nel 2002 e dall’anno successivo gli subentra nel ruolo Stefano Poggi (in quegli anni Presidente della Società Filosofica Italiana), che lo tiene fino al 2009, quando Segretaria diventa Gianna Gigliotti. Il merito dell’Istituto Banfi è quello di garantire al Convegno una stabilità istituzionale, organizzativa ed economica che consente anche di allargare il numero dei dottorandi che partecipano all’iniziativa. Questo stretto legame che si crea tra il Convegno e l’Istituto Banfi costituisce però la premessa per una situazione precaria nel momento in cui – visto il venir meno del sostegno degli enti pubblici al Banfi – l’Istituto non è più in grado di organizzare tale iniziativa. Questa crisi determina un’interruzione nell’organizzazione del Convegno, anche perché nessuna sede universitaria – per ragioni economiche – sembra essere in grado di gestire l’accoglienza di un numero così alto di dottorandi e professori.
QUARTA FASE (2013-2023)
La soluzione si profila agli inizi del 2013, quando alla Fondazione San Carlo di Modena si avvia una nuova fase nella storia del Convegno. Su iniziativa di Carlo Altini (direttore scientifico della Fondazione), l’ente modenese si propone come sede per l’organizzazione del Convegno a cadenza annuale, visto che può fare fronte ai problemi di ospitalità grazie alla struttura di accoglienza garantita dal proprio Collegio universitario. Inoltre, rispetto all’Istituto Banfi, la Fondazione San Carlo può mettere a disposizione del Convegno anche la struttura didattica e scientifica della propria Scuola Internazionale di Alti Studi, una scuola di dottorato che al proprio interno riserva un’attenzione particolare agli studi filosofici e che pertanto contribuisce ai lavori del Convegno non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche scientifico. Dal 2013 al 2019 il coordinamento scientifico del Convegno viene curato da Carlo Altini, Gianna Gigliotti e Stefano Poggi. Con la quiescenza di Gigliotti e Poggi, a partire dal 2020 il Comitato scientifico del Convegno è composto da Carlo Altini, Francesca Crasta, Mario De Caro, Costantino Esposito e Franco Ferrari. L’esperienza del Convegno alla Fondazione San Carlo termina con l’edizione del 2023, poiché internamente alla Fondazione si determina una diversa stagione istituzionale che non prevede la prosecuzione degli studi accademici e determina la chiusura della scuola di dottorato.
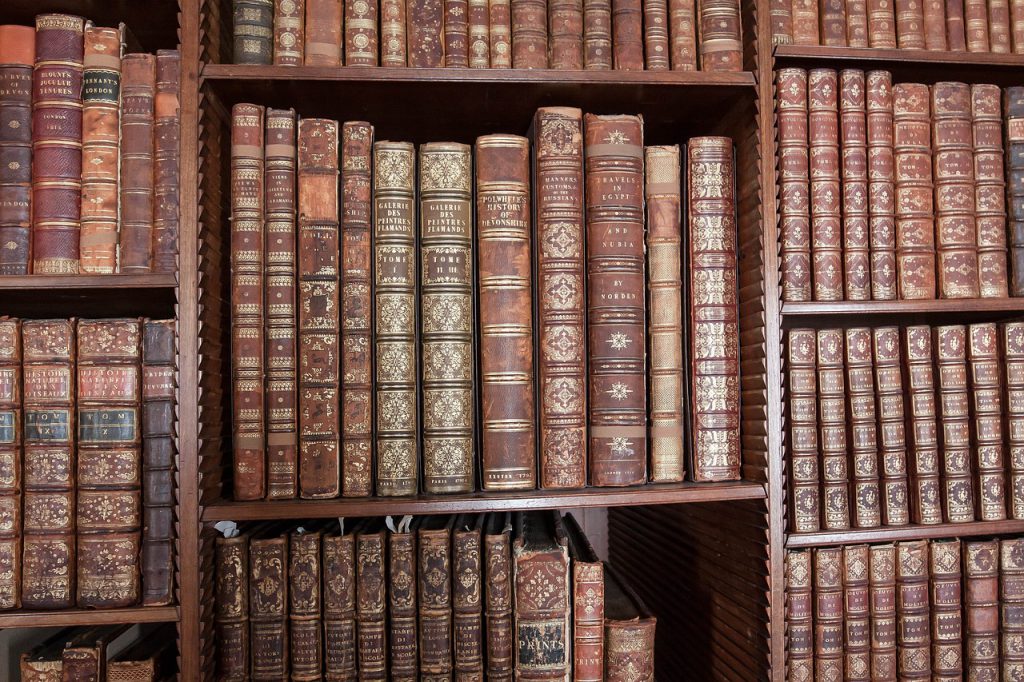
QUINTA FASE (2024-)
La fase attuale, che rappresenta la quinta, si avvia nel 2024. In questa fase non cambia il Comitato scientifico del Convegno, che continua a essere composto da Francesca Crasta, Mario De Caro, Costantino Esposito, Franco Ferrari e Carlo Altini, che è anche il direttore organizzativo dell’iniziativa. Il Convegno riprende però a essere itinerante in Italia, proprio per ovviare ai problemi determinati da un troppo stretto legame con un’istituzione. Tale legame ha naturalmente i suoi ovvi vantaggi in termini economici e organizzativi, oltre che di continuità, ma rischia di legare a doppio filo i destini del Convegno a quello dell’istituzione ospitante, esponendolo a crisi esogene ed estranee alla sua struttura. La cifra di questa nuova fase – la cui finalità è evidente anche nell’ideazione e nella realizzazione del presente sito web – consiste dunque in un tentativo di consolidamento del Convegno inteso come iniziativa accademica dotata di una propria indipendenza organizzativa e di una propria autonomia, nell’auspicio però che si allarghi il contributo offerto alla sua realizzazione da parte delle università, dei docenti di filosofia e delle società filosofiche italiane, contributo necessario anche per riflettere criticamente sui processi di formazione e di ricerca nelle diverse aree della filosofia.
Carlo Altini
(Professore ordinario di Storia della filosofia – Università di Modena e Reggio Emilia)
